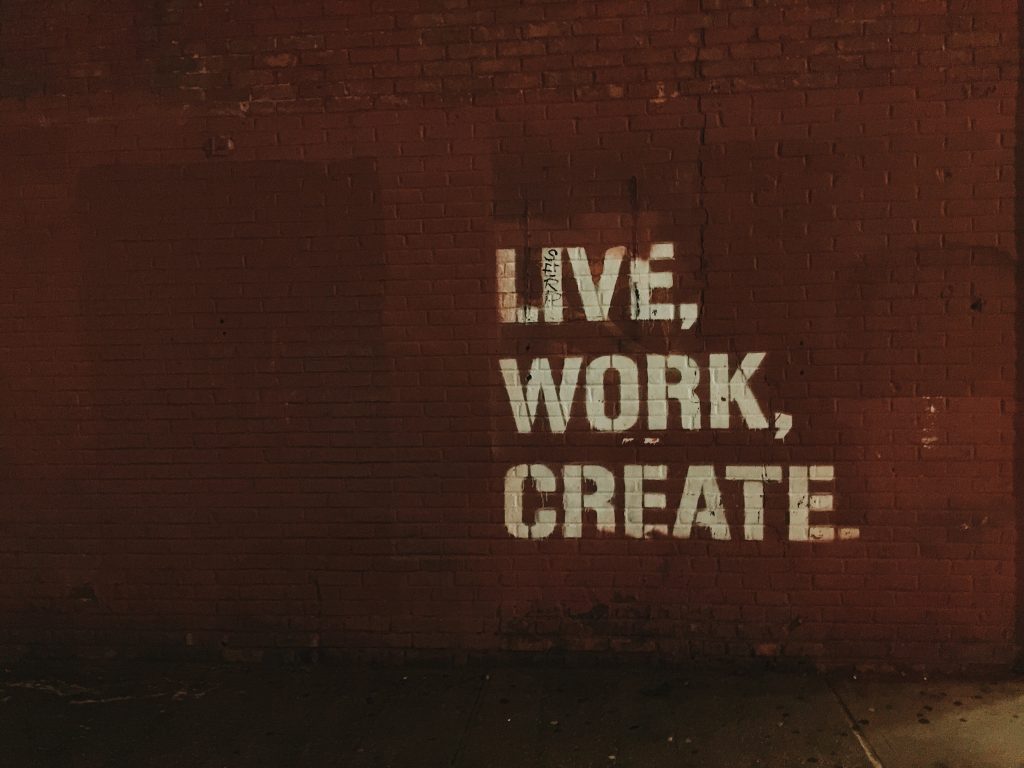Quanto sei disposto a farti pagare per i tuoi dati personali?
La privacy ha veramente un valore? Nell’era della trasformazione digitale e dei Big Data sembrerebbe proprio di sì. Ma quanti di noi si ricordano l’ultima volta che hanno letto i termini e le condizioni di utilizzo dei suoi dati prima d’iscriversi a un servizio online?
In pochi hanno scaricato l’app Immuni per il contact tracing e il monitoraggio dei contagi da Covid-19. Durante la sua evoluzione c’è stata un’alzata di scudi generale da parte di chi sosteneva che Immuni sarebbe servita a controllarci come fa la Cina, in modo manifesto e dichiarato, con i suoi cittadini.
Eppure nessuno sembra preoccuparsi di tutto quello che siamo liberamente abituati a usare online in cambio dei nostri dati. Il ragionamento è semplice: se un servizio web, che è costato decine o centinaia di migliaia di euro, per accedere ed essere usato ci chiede ‘solo’ i nostri dati personali, allora questi dati hanno un valore (economico) che non ci viene riconosciuto se non con la possibilità di utilizzo del servizio stesso.
Ma siamo sicuri che questo scambio sia equo da punto di vista economico?

Tu non ci pensi ai tuoi dati, ma loro sì
Il pioniere dello streaming online, Netflix, per anni ha continuato ad avere bilanci in rosso ma a crescere nel numero di abbonati e, ovviamente, nella quantità di dati immagazzinati nei suoi server. Tutte quelle informazioni serviranno a qualcosa, prima o poi. Oltre al fatturato da abbonamenti, è probabile che Netflix sappia già come creare valore, economico ovviamente, da tutti quei dati.
Corriamo da un social all’altro senza sosta, senza domandarci come vengano usati i dati che lasciamo. Usiamo nuove app di provenienza sconosciuta o poco chiara, come TikTok e FaceApp, senza preoccuparci dell’altro lato della medaglia, senza chiederci che cosa faranno dei nostri dati due paesi non proprio democratici, come Cina (TikTok) e Russia (FaceApp), che hanno il potere di controllo sulle aziende che hanno prodotto le due piattaforme.
Abbiamo paura del contact tracing sul modello cinese, ma lasciamo che minorenni di giovanissima età carichino i propri video su TikTok.
Tutti abbiamo paura delle conseguenze dell’uso della tecnologia di riconoscimento facciale, ma volontariamente carichiamo le nostre foto su un’applicazione russa di cui sappiamo pochissimo e nemmeno ci informiamo. Solo un anno fa, il senatore americano Chuck Schumer ha chiesto all’Fbi di indagare su FaceApp e i sospetti rimangono.

I dati sono o no un nostro diritto di proprietà?!
È giusto lasciare tutti questi dati liberamente ad aziende che grazie ai Big Data fatturano più del Pil di molti stati? C’è chi dico no, come l’imprenditore americano Andrew Yang che ha creato il Data Dividend Project (DDP), un movimento dedicato a riprendere il controllo dei nostri dati personali.
Non ci sono molte informazioni su come il DDP riuscirà a perseguire questo scopo, ma sembra che il principale obiettivo sia sensibilizzare e mobilitare le persone. Come si legge sul sito del progetto, i singoli consumatori non possono fare molto per combattere le grandi aziende o richiedere pagamenti per i dati, ma più persone sono coinvolte, maggiore è il loro potere.
L’obiettivo finale di Yang è che gli americani siano in grado di rivendicare i loro dati come un diritto di proprietà e di essere pagati se scelgono di condividerli.
Chi si iscrive al progetto, autorizza il DDP ad agire come agente autorizzato per esercitare i propri diritti legali ai sensi del California Consumer Privacy Act (CCPA) recentemente emanato. L’atto è entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno e offre ai consumatori in California il diritto di sapere come vengono raccolti e condivisi i loro dati personali, il diritto di chiedere che i loro dati vengano cancellati e il diritto di rinunciare alla vendita o alla condivisione delle loro informazioni personali. La legge proibisce inoltre alle aziende di vendere le informazioni personali dei consumatori di età inferiore ai 16 anni senza il consenso esplicito.
Noi europei qualcosa del genere lo abbiamo già sentito.

GDPR, un regolamento all’avanguardia
Dal 2018 in Europa è in vigore il GDP (General Data Protection Regulation), un regolamento a tutela dei dati che pone il nostro continente un grandino o due sopra agli altri.
Come abbiamo discusso anche noi nella nostra agenzia, grazie agli eventi di Singularity University Legnano Chapter, è il momento di parlare di etica, sia nelle tecnologie esponenziali, come l’intelligenza artificiale, sia in quelle digital, come Internet.
La free economy degli anni passati è forse arrivata al tramonto, molti invece dicono che ormai non si può più tornare indietro. Siamo abituati a lasciare dati per non pagare dei servizi che oggi fanno parte della nostra quotidianità.
Non possiamo però più pensare che lasciare i nostri dati ad altri, senza la consapevolezza preventiva e senza un controllo sul loro utilizzo, possa continuare a essere la regola. Il futuro che abbiamo davanti sarà sempre più automatizzato e digitalizzato, e i dati diventeranno sempre più importanti e preziosi, un vero strumento di potere.
Il GDPR è nato proprio per far fronte al trattamento dei dati e ha creato delle difficoltà a tutte quelle aziende che hanno clienti in Europa ma la sede in altri continenti. Alcuni siti hanno all’inizio addirittura scelto l’auto oscuramento per i visitatori europei pur di non doversi adeguare al nuovo regolamento.
Chi pensa che si tratti di un eccesso di burocrazia si sbaglia. L’Europa ha fatto un passo importante e ha segnato la strada. A chi si occupa di web marketing, il GDPR ha finalmente permesso di trasmettere il valore della qualità dei dati e della sicurezza con cui vengono gestiti.
Costruire delle liste di persone interessate al proprio business, per esempio, dal 2018 è più complicato, ma si è alzata di molto l’asticella della qualità e dell’attenzione a come questi database vengono costruiti. È aumentato anche il rispetto di molte aziende nei confronti dei dati degli utenti e, quindi, delle persone stesse.
Sono passati solo due anni dall’entrata in vigore del GDPR, la strada da fare è ancora lunga, ma non possiamo non ammettere che ha aiutato a creare una cultura del dato.